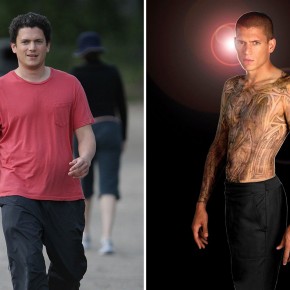Limetown – La serie di Facebook Watch che sognava di essere The Leftovers di Marco Villa
Limetown è una serie che punta altissimo, ma si complica la vita da sola e finisce per impantanarsi

Ci sono due cose interessanti in Limetown, la nuova serie di Facebook Watch, che ha debuttato sul social network il 16 ottobre (e che registra oltre 18milioni di views del primo episodio). La prima è che si tratta di una serie che sarebbe potuta andare in onda su una generalista, per impianto e respiro. La seconda è che affronta un tema che si posiziona all’esatto opposto di tutto ciò che gravita intorno al mondo Facebook. Al netto di questo, purtroppo, Limetown è anche una serie davvero poco convincente.
Limetown è il nome di una sorta di Milano 2 nel pieno della provincia americana: una città nata dalla volontà di un mezzo santone-ricercatore dal significativo nome di Oskar Totem, con tanto di mura e cancelli a separare dal resto del mondo. Durante un giorno come tanti, a Limetown spariscono tutti, ma proprio tutti, senza lasciare traccia. L’incubo di tutti i social network, insomma. L’unico che viene ritrovato è proprio il dottor Totem (sì, fa ridere), crocifisso e poi dato alle fiamme nella main street della città. Per il resto: nulla. Tutti evaporati nell’arco di poche ore, durante le quali Limetown è stata protetta da un misterioso esercito privato. La serie è ambientata 15 anni dopo questi avvenimenti, quando Lia, una giornalista e autrice di podcast interpretata da Jessica Biel, decide di rimettersi al lavoro su quel mistero, motivata dal fatto che tra gli scomparsi figura anche suo zio Emile (Stanley Tucci).

Meglio togliersi subito il pensiero, perché leggendo la trama e vedendo il primo episodio c’è un solo riferimento che risuona nella testa: The Leftovers. La serie di Damon Lindelof partiva da presupposti simili, ma lo sviluppo non sarebbe potuto essere più differente: tanto The Leftovers si concentrava sulla parte filosofica della questione, andando a raccontare i contraccolpi psicologici ed esistenziali dei sopravvissuti, quanto Limetown sembra volersi indirizzare verso un mystery fatto e finito.
E qui veniamo al primo dei punti segnalati in apertura: Limetown ha tutte le caratteristiche delle serie misteriose che hanno fatto la fortuna delle generaliste, con quel meccanismo di cliffhanger a fine puntata che garantiva la fidelizzazione di settimana in settimana. Allo stesso tempo, punta su un mezzo di comunicazione del tutto contemporaneo, non solo per la diffusione su Facebook, ma perché basata su un podcast di culto del 2015 e per la volontà di mantenere quel tipo linguaggio anche in formato seriale.
Con conseguenze tangibili: Lia registra tutto quello che fa e trasforma così i dialoghi in pezzi di intervista, aumentando a dismisura freddezza e distanza. È come se all’interno della serie ci fosse un ulteriore contenitore, che aggiunge formato e linguaggi estranei a quelli seriali, creando un doppio filtro tra lo schermo e lo spettatore. Un problema di adattamento, insomma. Il risultato è che Limetown non riesce a catturare, ma sembra procedere a tentoni: già solo nel primo episodio si contano diversi errori di sceneggiatura (su tutti la mancanza di riferimenti a quell’esercito privato citato in precedenza) e una generale insicurezza nella scrittura dei personaggi, che non riescono a imporsi.

Se il primo riferimento era Leftovers, il secondo è Under the Dome, serie molto meno riuscita di quella di Lindelof, che si faceva notare per la confusione generale e una scarsa chiarezza di indirizzo. Con Limetown siamo un po’ da quelle parti, con l’aggiunta di una Jessica Biel che appare clamorosamente fuori ruolo. Poi ovvio, nelle prossime puntate ci saranno senz’altro dei momenti di tensione ben strutturati o delle sottotrame interessanti, ma la forza di una serie mystery deve essere quella di catturare e tirare dentro all’istante. E questo in Limetown non accade. Ma proprio no.
Perché guardare Limetown: perché un mystery brutto è comunque un mystery
Perché mollare Limetown: perché è fredda e non coinvolgente